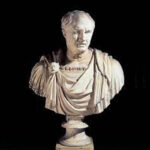La ribellione di Caio Albio Caleno verso Scipione l’Africano
Publio Cornelio Scipione è stato uno dei più grandi comandanti di sempre.
Noto semplicemente come Scipione l’Africano, il generale annientò l’esercito cartaginese nell’ultima battaglia di Zama.
Prima di partire per la penisola iberica, Scipione rinforzò l’esercito romano con truppe dei popoli italici.
Tra loro vi erano anche i soldati di Cales.
Nel 206 a.C., ultimo anno di permanenza del comandante in Spagna, Scipione si trovò al cospetto di un grave pericolo.
Gli accadimenti sono documentati, anzi raccontati con dovizia di particolari da Tito Livio e Polibio.
Il tutto nacque dalla falsa notizia che Scipione fosse stato colpito da una grave malattia.
La notizia creò scompigliò nella provincia iberica.
Indibile e Mandonio, due dei più irrequieti capi tribù dei forti Ilergeti, ripresero le armi contro i romani.
Con le truppe della Lacetania e della Celtiberia, saccheggiarono il contado dei Suessani e dei Sedetani, alleati del popolo Romano.
Ma il pericolo maggiore sopraggiunse dalle migliaia di italici che militavano nell’esercito romano.
“Civilis alius furor in castris ad Sucronem ortus. Octo ibi mília militum erant, praesídíum gentíbus, quae cis Hiberum incolunt, impositum.” (1)
Nell’accampamento collocato lungo il corso del fiume Sucro tra Cartagena e Terragona, scoppiò una sedizione.
Il malcontento dei soldati romani era dovuto alla mancata corresponsione delle paghe.
L’insoddisfazione spingeva alcuni militi ad uscire di notte per depredare sul territorio amico.
Altri, di giorno si allontanavano palesemente dalle insegne senza averne avuto il permesso.
I capi della rivolta
Tutto si svolgeva secondo la volontà e l’ostinazione dei soldati, senza rispetto degli statuti e della disciplina militare.
I militi speravano che i tribuni, presi dal medesimo furore, avrebbero partecipato alla ribellione.
I fenomeni di indisciplina si moltiplicarono fino a quando scoppiò un ammutinamento.
I legionari cacciarono i tribuni dalle loro tende e, da lì a poco, anche dagli alloggiamenti.
A capo della rivolta vi erano due soldati semplici:
Caio Albio Caleno e Caio Atrio Umbro.
“Erupit deinde seditio, postquam reprehendere atque improbare tribunos ea quae fierent et conari obuiam ire et propalam abnuere furoris eorum se futuros socios senserunt. fugatis itaque ex principiis ac post paulo e castris tribunis ad principes seditionis gregarios milites C. Albium Calenum et C. Atrium Umbrum delatum omnium consensu imperium est.” (2)
I due, non contenti per niente degli ornamenti tribunizi, osarono mettere le mani sulle insegne del sommo potere.
Nei giorni seguenti, i soldati attesero nuovi comunicati non solo della morte ma anche dei funerali di Scipione.
S’incominciò quindi a notare nei ribelli meno ardore e minore desiderio di compromettersi.
Anzi si cercarono i sobillatori e in un certo qual modo di nascondere i primi atti della rivolta.
Poi successe quello che alcuni temevano e altri auspicavano.
Infatti ben presto si seppe che Scipione era vivo e in via di guarigione.
Lo stesso Scipione inviò nell’accampamento sette tribuni militum.
All’inizio i funzionari non furono accolti bene.
Successivamente, seppero ricondurre la maggioranza a più miti consigli con discorsi calmi e concilianti.
Infatti, girando da principio intorno alle baracche dei soldati e poi inoltrandosi nelle tende dei capi e nel padiglione maggiore, come vedevano gruppi di persone che s’intrattenevano, parlavano con loro, chiedendo piuttosto quale fosse la causa del malcontento e dell’improvvisa agitazione.
La punizione da infliggere ai sobillatori
Nel frattempo, Scipione inviò degli esattori nei territori iberici a riscuotere i tributi imposti alle varie comunità.
Le somme ricavate servivano al pagamento degli stipendi arretrati dei propri soldati.
Per mezzo di un editto poi invitò tutti i rivoltosi a recarsi personalmente a Cartagena per ritirare le spettanze.
I legionari avevano la possibilità di presentarsi tutti insieme o singolarmente.
Naturalmente la maggioranza decise di andare in massa perché si sentiva più sicura.
In quegli stessi giorni, Scipione tenne a Cartagena un consiglio di guerra per decidere la punizione da infliggere ai rivoltosi.
Le tesi alternative erano:
- punire i soli autori della sedizione (e non erano più di trentacinque)
- vendicare una ribellione, più che sommossa di tanto pessimo esempio, con il supplizio di un numero maggiore
Prevalse l’opinione “più mite” in modo che la pena si fermasse dove era nata la colpa.
Quanto alla moltitudine, bastava una reprimenda.
Congedato il consiglio, circolò la voce che si fosse discusso della spedizione contro Mandonio e Indibile.
Scipione intanto aveva imposto ad ognuno dei sette tribuni di far arrestare con l’inganno cinque capi ribelli.
Intanto, dopo che i 35 caporioni furono imprigionati all’insaputa degli altri Italici (3), si seppe che l’esercito romano con Marco Silano si sarebbe spinto il giorno seguente nel territorio dei Lacetani.
Questa notizia rassicurò del tutto gli Italici, vedendo che Scipione non aveva alcuna intenzione di perseguitarli.
Ma in verità le truppe non partirono.
I ribelli sub occasum solis entrarono a Cartagena verso sera, mentre l’esercito romano fece finta di prepararsi per la partenza.
Il discorso di Scipione
Alla veglia quarta, i bagagli dell’esercito, di cui si fingeva la partenza, cominciarono a muoversi.
Sul far del giorno si avanzarono le insegne e alla porta si ordinò l’alt ai reparti militari schierati.
Poi inviarono le guardie a tutte le porte perché nessuno uscisse dalla città.
Intanto, gli Italici, arrivati il giorno prima, furono invitati ad una adunanza e corsero con fierezza al tribunale.
Ma ad un tratto quest’ultimi si videro circondati dai soldati armati richiamati dalle porte e, vedendosi inermi, si calmarono.
Stando a quello che gli stessi ribelli confessarono, nulla li turbò tanto quanto il vedere Scipione vigoroso e pieno di energia, mentre se l’erano immaginato sofferente.
Scipione sedette in silenzio per qualche istante.
Poi fu informato che gli autori della rivolta erano giù in piazza, e che tutto era pronto.
Allora, fatto intimare il silenzio dal banditore, cominciò il discorso.
Secondo l’opinione comune, Tito Livio riportò il suo lungo discorso probabilmente inventato se non tutto in larga parte.
Tuttavia, l’arpinate trasmise il senso dell’orazione del comandante romano.
“Voi avete conferito la suprema autorità degli auspici in mano a Umbrio Atrio e a Caleno Albio.
Negate si certo, o soldati, che tutti abbiate fatto o voluto fare questo; essere questo stato l’ira, la frenesia di pochi, e volentieri vi crederò.
Poiché sono stati commessi tali misfatti che, se si diffondessero a tutto l’esercito, non potrebbero essere espiati, se non con grandi supplizi.”
“Vos auspicium et imperium ad Umbrum Atrium et Calenum Albium detulistis. negate vos id omnes fecisse aut factum voluisse, milites; paucorum eum furorem atque amentiam esse libenter credam, negantibus; nec enim ea sunt commissa quae, volgata in omnem exercitum, sine piaculis ingentibus expiari possint.” (4)
Il comportamento ambiguo dei rivoltosi
Scipione mise i legionari di fronte al loro comportamento ambiguo, contrario al giuramento del soldato e al dovere del cittadino.
Sottolineò che avevano trasferito il comando a coloro che non avevano mai avuto uno schiavo a cui comandare.
Albio ed Atrio si collocarono nel pretorio.
La tromba suonò presso di loro.
Una volta chiesto il segno, essi sedettero sul palco di Publio Scipione.
Anticipati dal littore, avanzarono fra due schiere di soldati, avendo dinanzi a loro i fasci con le scuri.
“In praetorio tetenderunt Albius et Atrius; classicum apud eos cecinit; signum ab iis petitum est; sederunt in tribunali P. Scipionis; lictor apparuit; summoto incesserunt; fasces cum securibus praelatis sunt.” (4)
Scipione continuò la sua orazione.
“Or dunque, per quanto vi riguarda tutti insieme, se dell’errore vi pentite, sono pago.
Vi ho punito abbastanza.
Albio Caleno ed Atrio Umbro, e gli altri autori dell’infame sedizione, pagheranno con il sangue il misfatto commesso.
Lo spettacolo del loro supplizio, se siete tornati in voi stessi, deve essere non solo non atroce, ma perfino gradito.”
“Itaque quod ad universos vos attinet, si erroris paenitet, satis superque poenarum habeo:
Albius Calenus et Atrius Umber et ceteri nefariae seditionis auctores sanguine luent quod admiserunt.
Vobis supplicii eorum spectaculum non modo non acerbum sed laetum etiam, si sana mens rediit, debet esse.” (5)
La condanna a morte
Terminato il discorso, fu eseguita la condanna a morte di tutti i 35 caporioni della rivolta.
L’esercito, che aveva circondato l’assemblea, batté le spade sugli scudi.
Si udì la voce del banditore chiamare per nome i condannati a farsi avanti.
Tirati fuori nudi nel mezzo della piazza e legati al palo, furono battuti con le verghe e decapitati con la scure.
I presenti rimasero impietriti di fronte a quella scena di orrore tanto da non emettere neanche un lamento.
Poi, rimossi i corpi e ripulita l’area, i soldati giurarono obbedienza a Scipione nelle mani dei tribuni.
Ognuno di loro ricevette la paga per appello nominale.
Ebbe così fine la rivolta dei soldati iniziata a Sucro.
La ribellione fu sedata con una mistura di terrore e di generoso perdono in un’epoca particolare della storia di Roma.
Bibliografia:
1) Tito Livio, Ab Urbe Condita – Libro XXVIII, 24
2) Tito Livio, Ab Urbe Condita – Libro XXVIII, 26
3) Polibio, Le Storie, Libro XI, fr. 30°, i
4) Tito Livio, Ab Urbe Condita – Libro XXVIII, 27
5) Tito Livio, Ab Urbe Condita – Libro XXVIII, 29
© Riproduzione riservata