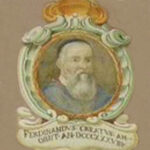Il legame tra l’Abbazia di San Vincenzo al Volturno e Calvi
Le vicende storiche dell’Abbazia di San Vincenzo al Volturno s’intrecciano con quelle di Calvi.
Il monastero è uno storico cenobio benedettino posto nel territorio di due comuni in provincia di Isernia:
Castel San Vincenzo e di Rocchetta a Volturno.
Secondo il Chronicon Vulturnense, l’abbazia nacque grazie ai nobili beneventani, tali Paldone con i suoi cugini Tatone e Tasone, fratelli.
Nel 703, i tre Re Magi s’incamminarono alla volta del regno dei Franchi, scegliendo la vita monastica.
Lungo il percorso, sostarono nel cenobio di Farfa in provincia di Rieti.
Qui incontrarono l’abate Tommaso di Maurienne.
Anche quest’ultimo era stato protagonista di un viaggio dal luogo natale in Savoia alla Terra Santa.
A Gerusalemme, sul Santo Sepolcro, gli apparve Maria.
La madonna lo invitava a tornare in Italia, in Sabina, per cercare un luogo di culto dedicato a lei.
Tommaso avrebbe riconosciuto il luogo grazie a tre altissimi cipressi.
Là si sarebbe fermato per ricostruire il cenobio che era stato eretto nel V secolo in onore della Vergine.
Così anche Paldone, Tasone e Tatone decisero di seguire le indicazioni di Tommaso.
“Vi è un luogo, o dilettissimi figli, nel quale desidero che andiate, nelle regioni del Sannio, sulla riva del fiume Volturno a circa un miglio dalla sorgente.”
In questo luogo si trovava una cappella consacrata dedicata a Vincenzo, diacono e martire di Saragozza.
Da ambo i lati del fiume vi era un bosco foltissimo, nel quale si nascondevano ladri e belve feroci.
Ma il Signore lo avrebbe reso sicuro dalle scorribande dei farabutti a tutti coloro che avessero compiuto il cammino.
Infine, avrebbe consentito la crescita degli alberi da frutto al posto degli arbusti spinosi e dei cespugli.
Dunque Tommaso ripeté: “andate, o figli, andate e rimanete in quel luogo senza timore“.
Il centro nevralgico di Calvi
Dall’altra parte, Calvi, fin dall’antichità, è stato il centro nevralgico dell’agro caleno e non solo.
Dal IV all’VIII sec. d.C., le ripetute devastazioni provocate dalle invasioni barbariche determinarono la decadenza di Cales.
Successivamente, l’arrivo dei Longobardi ed il conseguente rafforzamento del loro dominio consenti alla popolazione di ritornare a vivere in pianura.
Così a Calvi fu costruita la nuova città fortificata.
Al suo interno, l’elevazione del castello consentì alla popolazione di dominare dall’alto il territorio e di contrastare i nemici.
La cittadina calena iniziò ad espandersi oltre la cinta muraria, inglobando terre e centri abitati.
Il primo accostamento tra il cenobio molisano e Calvi avvenne verso la fine dell’anno mille.
La notizia relativa all’argomento ci è offerta dal Chonicon Vulturnense.
Nel 988, l’abate Roffredo del monastero di San Vincenzo al Volturno raccolse diverse “villas” ed “hereditates” nel territorio caleno.
Fra queste fece edificare una chiesa che intitolò a San Vitaliano.
“Roffridus abbas Sancti Vincencii, sedit e annis. XIIII. iste conduxit homines, et habitare fecit in colli Sancti Angeli, et in Baccaricias, et in locum ubi dicebatur ad Ficum et in Cerrum, villas quoque in Calvo, ubi ecclesiam edificavit vocabulo Sancti Vitaliani, ubi plures recollegit hereditates per has scripciones.” (1)
Il 24 gennaio 1059 fu innanzato al soglio pontificio Niccolò II.
Il papa, talvolta chiamato Nicola Ii, emise una bolla datata 3 marzo 1059 (“V nonae Martii 1059“).
Tra le altre chiese che confermò al Monastero di S. Vincenzo al Volturno vi erano:
“in Calvo Ecclesiam S. Iuliani et S. Vitaliani”.
Le chiese erano anche menzionate nel terzo volume dell’opera del monaco cassinese Giovanni.
In Calvo ecclesiam Sancte Iulianes, et Sancti Vitaliani (2)
Il conte normanno Umfredo d’Altavilla
Nel 1077, il conte normanno di Calvi Umfredo d’Altavilla, della stirpe di Roberto il Guiscardo, fece una concessione al cenobio.
“E il monastero di san Vincenzo con gli uomini e tutte le sue pertinenze; due mulini che sono nel Laneo presso pontem silicis; sei villici che Umfredo di Calvi diede al predetto monastero; un mulino pertinente al monastero che è presso Calabrizitum nell’acqua del Lanei con tutte le sue pertinenze e i predetti villici.”
“et monasterium Sancti Vincentii cum hominibus et omnibus suis pertinentiis et duo molendina que sunt in Laneo ad pontem silicis. et sex villanos quos Omfridus de Calvo iamdicto monasterio dedit. et unum molendinum pertinens monasterio quod est ad Calabrizitum in aqua Lanei. cum omnibus pertinentiis suis et predictis villanis” (3)
L’attribuzione dei sei villaggi al cenobio è confermata da un altro documento redatto nel 1109.
“e il monastero di san Vincenzo con gli uomini e tutte le sue pertinenze, e due mulini che sono presso pontem Silicis, e sei villici che Umfredo di Calvi diede allo stesso monastero.”
“et monasterium Sancti Vincentii. cum hominibus et universis eius pertinentiis. et duo molendina quae sunt ad pontem Silicis. et Sex villanos quos Omfridus de Calvo dedit ipsi monasterio.” (4)
Il cenobio sotto la giurisdizione di Calvi
Nel 1276, il Monastero di San Vincenzo al Volturno risultava essere posto sotto la giurisdizione di Calvi.
Il Giustiziario di Terra di Lavoro, ricevuta una denuncia dall’abate e del convento di San Vincenzo al Volturno sugli eccessi commessi da Bertrando del Balzo ai danni dei vassalli del suddetto Monastero nel territorio di Calvi, ordinò di compiere accurate indagini preliminari.
Le vessazioni perpetrate dal conte di Avellino descritte dall’abate riguardarono:
- richiesta di sovvenzioni forzose ed illegali
- detenzioni in carcere
- appropriazione indebita di animali.
“Iustitiario Terre Laboris, recepta querela Abbatis et conventus S. Vincentii de Vulturno super excessibus Bertrandi de Baucio Comitis Avellini, commissis contra vassallos pred. Monasterii in territorio Calvi, mandat ut de premissis inquisitionem diligentem faciat; cum pred. Abbas exposuerat quod pred. Comes vassallos eosdem ad illicitas subventiones compellebat, alios carcere detinebat et animalia eorum capiebat.
6 giugno 1276, IV Ind. (5)”
Nel 1495, monsignor Angelo Marotti fu nominato Vescovo di Calvi.
In quel periodo, la Cattedrale calena necessitava di urgenti lavori di ristrutturazione, sebbene fosse sprovvista di rendite.
Così, per reperire I fondi necessari, ottenne con le preghiere l’unione della chiesa di San Vitaliano alla nostra Mensa Episcopale.
La chiesa, come affermato precedentemente, fu fondata da Roffredo ed apparteneva alla comunità religiosa di San Vincenzo al Volturno.
All’Abate del monastero, il vescovo versava sei ducati annui nel giorno della ricorrenza di San Vincenzo, il 22 gennaio.
La cifra pattuita si consegnava ai cassinesi.
Angelo Marotti o Angelo Mazziotta?
Da allora il Vescovo di Calvi ebbe anche il titolo di Abate di San Vitaliano
Al contrario, il prelato aveva l’obbligo di dotare la chiesa sparanisana di tutto il necessario.
Tali vicende sono menzionate nella Platea del Vescovo Fabio Maranta:
“Item tenetur solvere ducatos sex Rectori seo Abbati Abbatiae nuncupatae S. Vincentii dello Volturno in festivitate S. Vincentii, quae celebratur vigesima secunda mensis Januarii cuiuslibet anni, pro Ecclesia S. Vitaliani sita in Villa Sparanisii prius Grancia dictae Abbatiae S. Vincentii dello Volturno, deinde unita dictae Mensae Episcopali Calvensi cum dicto onere, precibus et supplicationibus R.mi Angeli Marotta tunc temporis Episcopi Calven, tempore quo tota Ecclesia Major dicti Episcopatus corruerat et iverat in collapsu, pro reaedificatione dictae Ecclesiae ut sopra dirutae et collapsae, ut habitum est ex relatione antiquorum et senium dictae Civitatis Calvensis.” (6)
Da questo documento redatto nel 1588, si evince che, quasi un secolo dopo, la tradizione calena dell’elargizione era ancora radicata.
Tuttavia, secondo alcune fonti autorevoli, l‘unione della chiesa alla Mensa di Calvi avvenne cinquant’anni prima del 1495.
Nel 1441, Angelo Mazziotta salì sul soglio episcopale di Calvi.
Il canonico, originario di Capua, riedificò nel 1445 la cattedrale a causa di terremoti ed incursioni.
La lastra marmorea di un vescovo giacente collocata alla sinistra della porta di accesso alla sacrestia raffigura proprio lui.
Bibliografia:
1) Chronicon Vulturnense del monaco Giovanni, II, Pag. 301
2) Chronicon Vulturnense del monaco Giovanni, III, Pag. 93
3) Regii Neapolitani Archivi Monumenta: edita ac. Illustrata, Vol. V, pp. 231-235, doc. CCCCLXXXIX, a. 1097
4) Regii Neapolitani Archivi Monumenta: edita ac. Illustrata, Vol. V, pp. 336-340, doc. DXXXIV, a. 1109
5) Reg. Ang. XIII (1275-1277), p. 259, n. 227
6) Platea di Fabio Maranta, foglio 146
© Riproduzione riservata